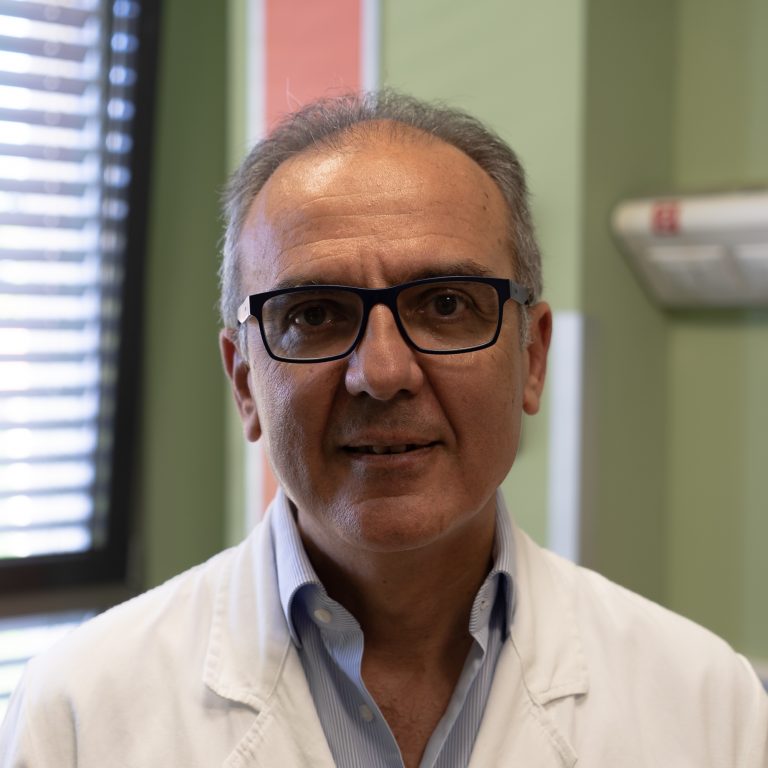“Se potessi ripartirei per l’Africa domani”. Vincenzo Lucchetti era un giovane chirurgo già affermato quando decise di mollare la sua vita e il suo lavoro fiorentino per andare a operare nel continente africano. “L’idea di fare un’esperienza in Africa ce l’avevo fin da quando avevo preso la specializzazione in chirurgia. Un giorno, operai un frate cappuccino toscano. Durante le mie visite post operazione per vedere come stavano i malati mi misi a chiacchierare con lui che mi raccontò di essere missionario in Tanzania. Gli raccontai il mio desiderio e lui mi propose: ‘Dottore, perché non viene a trovarci?’. “Quasi quasi’ risposi”.
Lucchetti prese tre mesi di aspettativa e fece il giro delle missioni cappuccine toscane in Tanzania. “Mi piacque, tornai in Italia e decisi di ripartire”. Era il 1980. “Ripartii per l’Africa con questa associazione di volontariato di Milano come chirurgo, prima in Togo, poi in Somalia, in Benin e in altri paesi. Conobbi Guido Bertolaso che allora era il responsabile sanitario della Cooperazione italiana che mi propose di andare a lavorare con lui”. Lucchetti accettò. Andò al Dipartimento della Cooperazione del Ministero degli Esteri e iniziò a fare il cooperante: faceva parte di un gruppo di sei medici, guidati da Bertolaso, che dovevano coordinare i progetti portati avanti dal Ministero in varie parti del mondo.
“A un certo punto feci il concorso per entrare al Ministero e lo vinsi, ma avrei dovuto licenziarmi dall’ospedale. Così rinunciai e tornai a fare il chirurgo a Firenze”. Quando è andato in pensione, nel 2012 però è tornata la voglia d’Africa. “Sono ripartito: Sierra Leone, Angola e Repubblica Centrafricana, per altri sei anni”. Nel 2018 è dovuto rientrare. Ma poi è arrivato un altro incontro che ha cambiato di nuovo la sua vita: quello con il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, che gli ha offerto la guida della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Qui ha potuto mettere ancora la sua esperienza e la sua attenzione agli altri al servizio di chi ne ha più bisogno, facendo tesoro di quanto imparato in giro per il mondo, soprattutto in Africa.
“L’Africa mi ha cambiato molto, sono esperienze molto forti. Nell’ultimo periodo della mia carriera a Firenze ero direttore del dipartimento chirurgico che contava 80 chirurghi: se mancavi tu, c’era comunque qualcuno che poteva prendere il tuo posto. In Africa invece ci sono stati dei momenti in cui ero l’unico chirurgo nel raggio di 500 chilometri: in Eritrea, dove c’era la guerra fra eritrei ed etiopi, ero l’unico chirurgo civile ad Asmara e avevo 240 letti di chirurgia. Quindi mi sentivo davvero utile e indispensabile: non fai solo qualcosa per gli altri ma anche per te, ti senti gratificato dal fatto di vedere la salvezza di alcune persone che se non ci fossi stato tu sarebbero certamente morte”. “In Africa – continua Lucchetti – per operare usi quello che c’è, devi cercare di risolvere il momento della difficoltà. In Africa torni alle radici dei bisogni, in cui i problemi veri sono fame, morte, guerra ma nonostante le difficoltà la gente affronta la vita con un sentimento positivo. Ti accorgi della sovrastruttura che noi abbiamo”.
Ricorda per esempio la sua esperienza in Togo: “E’ un paese splendido, animista, in cui c’è una sensazione di magico ovunque. Ero in un ospedalino perso nella giungla e la sera c’erano i tamburi dei villaggi vicini che suonavano. Lì le persone considerano ogni fatto a se stante: c’era un’infermiera che lavorava da 20 anni in un ospedale cattolico: un giorno la figlia prese il morbillo, l’ha portata dallo stregone ed è morta. La seconda, col morbillo, l’ha portata in ospedale ed è guarita. Quando anche il terzo figlio ha preso il morbillo, la logica avrebbe voluto che lo portasse in ospedale, invece l’ha portato dallo stregone”. In Togo “non esisteva l’anagrafe: per avere i documenti bastava andare nell’ufficio con due testimoni e dichiarare l’età. Ho visto persone vecchissime che sui documenti avevano 18 anni. Poi in ospedale assistevo spesso a un fenomeno strano: c’erano pazienti che miglioravano e cominciavano a stare bene, poi inspiegabilmente peggioravano fino a morire. Non capivo il perchè finchè non mi accorsi che erano i parenti, che cucinavano nel prato davanti all’ospedale e portavano il cibo ai pazienti ricoverati, ad avvelenarli, perché lo stregone aveva detto che non dovevano vivere perché magari aveva fatto un torto a un dio”.
L’esperienza in Africa ha cambiato il modo di vedere il mondo, anche a Firenze. “Noi pensiamo che la nostra cultura sia superiore, senza volerlo, o a volte volendo, cerchiamo di esportare il nostro modo di vita e il nostro sistema a di valori ma non è detto che sia quello che funziona: abbiamo un sistema capitalista che non mi sembra dia la felicità a tutti. Quindi bisogna avvicinarsi con rispetto a una situazione diversa: se ti avvicini con rispetto alle altre culture e agli altri usi capisci che quello in cui pensi di credere può essere messo in discussione.”
Questo modo di vedere le cose lo aiuta anche nell’impegno in Fondazione. “Sono entrato in contatto con una parte dell’umanità che ha bisogno, in cui la difficoltà di vivere è enorme. Mi sono accorto che la povertà è frutto di un’ingiustizia sociale, di regole che non vanno, di una non equa ridistribuzione del reddito. L’ultima missione che ho fatto era nella Repubblica Centro Africana: potrebbe essere la Svizzera d’Africa, nel sottosuolo ha di tutto, ma è l’ultimo paese in tutte le graduatorie perché gli si porta via tutto. Di fronte a questo o dici ‘Non ne voglio saperne niente’ ma allora gli lasci quello che hanno, o prendi tutto ma in qualche modo te ne devi fare carico”. L’esperienza a contatto con le parti più povere del globo “mi ha lasciato il senso di ingiustizia sociale. Così provo a fare qualcosa contro queste ingiustizie nell’agire quotidiano. In Italia il ceto medio sta sparendo e scivolando sempre più verso la povertà, mentre i ricchi sono sempre più ricchi. Non è un modo giusto questo, ma voglio continuare a provare a fare qualcosa”.

 Ivana Zuliani
Ivana Zuliani